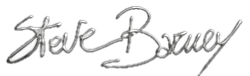Shaning
Una notte, sette anni fa, la visione: “Avevo appena finito di rivedere “Shining” di Stanley Kubrick quando sullo schermo televisivo sono apparse le prime immagini sfocate e buie di una grande nave boccheggiante piegata su un fianco. Da quel momento ho rivisto per ore e ore insonne sul divano di casa fino all’alba e poi ancora e ancora quelle immagini di una tragedia senza senso che capovolgeva la realtà”. Stefano Bergamaschi inizia a raccontare così lo shining che l’ha portato alle pareti che divennero pavimenti: “In quel preciso momento ho avuto un transfert tra l’hotel Overlook sommerso dalla neve nel Colorado e quella nave da crociera piagata, sommersa e piegata che si stava coricando sugli scogli del Giglio. Dentro di me ho cominciato a fantasticare, a immaginare che cosa sarebbe potuto accadere se in quel preciso momento a bordo ci fossi stato io. Da allora non ho più smesso di pensare al capovolgimento della prospettiva della vita”.
Il referente teorico principale di Shining e di Stephen King è un saggio breve scritto da Freud, “Il Perturbante”, definito da Kubrick “il massimo discorso fatto dalla cultura occidentale sul tema della paura”. In questo saggio Freud cerca di spiegare quel sentimento spaventoso e perturbante (“unheimlich” in lingua tedesca) che trae origine dal suo essere sconosciuto e inconsueto: “il perturbante sarebbe […] qualcosa in cui, per così dire, non ci si raccapezza.”, quando la realtà quotidiana viene improvvisamente capovolta lasciandoci smarriti nella doppiezza di senso che si ritrova anche nel nome dell’hotel di Shining. Il verbo inglese “to overlook” può avere infatti un duplice significato: “controllare con lo sguardo, ispezionare, sorvegliare” quanto “lasciarsi sfuggire, tralasciare”.
“Quel corto circuito ha rivoluzionato la mia visione, le mie immagini, il mio modo di vedere. In sette anni ho sviluppato questa nuova tecnica con acrilico e polvere di colore che mi consente di rivisitare completamente una fotografia facendola diventare qualcosa che non è più reale”.
La fotografia è stata per Steve Barney alias Stefano Bergamaschi la culla dei segni, sin da quando nei primi anni ’80 stampava e ristampava nella camera oscura improvvisata in bagno le pellicole Ilford bianco e nero impressionate da una Praktica semiautomatica sgranata e sbilanciata dall’enorme Sigma 180. “Il primo quadro che ha lasciato un segno dentro di me è stata una fotografia di Man Ray, “Le violon d’Ingres”, scatto scandaloso ai tempi, avanguardia pura. Man Ray non si accontenta di immortalare la schiena nuda e conturbante dell’amata Kiki di Montparnasse, ma dipingendo con l’inchiostro nero due effe di violino sui suoi fianchi l’ha trasformata in uno strumento ad arco metafisico e immortale”.
Vito Oliva
Una contaminazione tra fotografia e pittura, tra realtà e visione, che accompagna Steve Barney nel viaggio quasi trentennale che l’ha portato dal negativo al positivo, dalla celluloide alla tela, dalle fredde e torride notti sulle colline piacentine a Hong Kong e alla Biennale di Venezia. Un viaggio costellato di simboli e contaminazioni , di tecniche e materiali, dalle finestre ai nodi, dalle Marilyn slim (i pacchetti di sigarette scovati a Sofia) a Greta Garbo, dalle mani e le teste dei manichini alla bambola sottratta alla figlia Meggie, inseriti e annodati sulle tele prima cementificate, poi base bianca con l’olio e dopo un mese di essiccazione naturale irrorate da pennellate di colori intensi a suon di musica in uno studio in cui troneggia una batteria: “La suono spesso per affinare l’ispirazione di quello che andrò a realizzare».
“Io non mi considero né un pittore né un’artista. Sono un’ape che vola di fiore in fiore, cerco continuamente immagini in cui intravvedo un cambiamento totale, la possibilità di una rielaborazione, di una trasformazione, sino a creare un ‘immagine completamente ribaltata in cui io vedo un cambiamento totale. Cerco qualcosa di nuovo nell’arte anche se l’impresa, dopo Picasso, è praticamente impossibile. Mi faccio guidare dall’istinto, non so dove voglio arrivare. Non sono un geometra. Parto da una situazione. Più un’immagine è difficile, più è intrigante la sfida per arrivare ad un risultato se non superlativo, per me soddisfacente”
“Quando le pareti divennero pavimenti” non è che l’ultimo naufragio di un artista irrequieto e bulimico alla disperata ricerca di un senso della vita: “Il primo quadro è stato quello del “Ponte 1”, deck 1 Olanda. Il secondo è stato “L’ultima ciambella”, Ho impiegato 12 mesi per arrivare a un risultato che mi convincesse, ho faticato parecchio. Non è che un’opera viene al primo colpo. Ma non mi arrendo”.
A differenza di Jeff Koons, Damien Hirst e Bansky, bravi a suscitare un’emozione, uno shock visivo milionario, le opere di Barney necessitano un secondo sguardo.
Il quadro che dà il titolo alla mostra capovolge la prospettiva dei visitatori alla ricerca del “Metacentro perduto”. “Shining”, con il marinaio sullo sfondo del lungo corridoio, il contrasto e l’opposizione fra qualcosa che sembrava sicuro diventato infido, “Natura morta”, e ancora ricapovolto durante le operazioni di salvataggio “Alla ricerca del tempo perduto”.
Il naufragio come metafora, l’immagine figurativa che affonda nel colore, dentro le visioni metafisiche della mente. L’immagine reale naufraga dentro un’immagine astratta e da questa idea astratta nasce una nuova realtà onirica.
Una soglia da non varcare nello spazio tempo, la camera numero 237 dell’Overlook hotel, transfigurata sulla soglia della cuccetta “1233”. “Squarci”, “Metaspazi”, “Fuori asse” che si aprono sull’esistenza costellata da finestre segrete, da “Secret Windows”, in “Sotterranea” e “Chiaroscuro”. “Quel che resta del giorno” si tiene insieme grazie ai “Fili di lana” e a “Il nodo” ritrovato – “per me sono una miscela tra l’action painting di Pollock e i colori di Miro” – grazie ai “Graffiti” di un’altra dimensione costellata dal faro rosso de “I sogni muoiono all’all’alba” che prendono il volo, anch’esso rosso, di “Rinato”
“Volevo dare colore a qualcosa che non aveva più colore. Il mio leit motiv è dal negativo trarre il positivo. Anche se non è facile. Durante il percorso creativo di questa mostra il mio stato d’animo è cambiato continuamente ma ho voluto con tutte le mie forze presentare questo progetto a Genova dove la Concordia è stata portata e smontata pezzo dopo pezzo. Per me Genova è una fine ma anche un punto di partenza per trovare una sintesi tra figurativo e astratto, tra il dolore e la speranza”.
Sicuramente l’arte possiede quella “luccicanza” che consente di rivivere eventi passati e prevedere eventi futuri annullando il tempo e facendo affiorare i segreti nascosti, rimuovendo la paura senza oggetto, che si sottrae alla ragione.
Le pareti e i pavimenti di Barney ci aprono gli occhi per guardare il fondo guardando in alto alla ricerca di “un centro di gravità permanente” che renda “dolce naufragar in questo mare”. Diceva Flaubert: più parole si spendono su un quadro, più quel quadro deve essere brutto. Concetto ben chiaro a Stefano Bergamaschi, uomo di poche parole, che senza quelle pennellate dissiperebbe la sua esistenza come Barney Panofsky
Intervista di
Vito Oliva